Meditazione n. 8
«BEATI I PERSEGUITATI PER CAUSA
DELLA GIUSTIZIA,
PERCHÉ DI ESSI È IL REGNO DEI CIELI»
1. Due motivi di persecuzione: la giustizia
e il nome di Cristo
La beatitudine dei perseguitati è una delle poche
(quattro in tutto) attestate sia da Matteo che da Luca
ed è l'unica ad essere seguita da un breve commento
dello stesso Gesù.
Uno sguardo sinottico al testo rispettivo di Matteo e di Luca (vedi allegato)
aiuterà a capire meglio le riflessioni che
seguiranno.
L'elemento che meglio distingue e caratterizza le
due versioni è il motivo per cui si è perseguitati:
«a causa del Figlio dell'uomo» per Luca,
«per la giustizia» secondo Matteo.
Nel primo caso, si tratta di un motivo cristologico: beati sono
proclamati i discepoli
che soffrono per la loro fede in Cristo; lo
sfondo è storico: si ha di mira la situazione concreta
della Chiesa,
che è oggetto di discriminazione e di
ostilità da parte
del mondo circostante, all'inizio soprattutto
giudaico.
Nel secondo caso, il motivo è morale e lo sfondo
universale; destinatario della beatitudine non
è un gruppo ben preciso («Beati voi...»), ma sono tutti
quelli che sono perseguitati per la
giustizia.
Resta anche in Matteo la motivazione cristologica
(«per causa 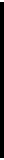 mia»),
ma essa assume una portata più ampia. mia»),
ma essa assume una portata più ampia.
La giustizia di cui si parla è certamente quella del
Vangelo, la giustizia del Regno («Cercate il regno di Dio e la
sua giustizia...»), che si esprime in «opere di giustizia» (Matteo 25), ma proprio per questo è una categoria
più universale e inclusiva che non la persona storica
di Cristo.
Possiamo scorgere una certa evoluzione nel modo
con cui questa beatitudine è stata
interpretata nel corso dei secoli.
Nell'antichità e, in parte, per tutto il medioevo prevaleva il motivo
cristologico di Luca; martiri erano considerati soltanto coloro che
erano stati
perseguitati per la fede in Cristo.
Nell'epoca moderna,
soprattutto ai
nostri giorni, ha assunto una importanza
nuova
il motivo morale e universale «per la giustizia».
Martiri sono considerati (anche dalla Chiesa ufficiale)
non soltanto quelli che vengono messi a morte
formalmente per la fede in Cristo, ma anche quelli
che
danno la vita per amore del prossimo, come san
Massimiliano Maria Kolbe; quelli che muoiono per
difendere i diritti degli oppressi, come Oscar Romero;
quelli
che muoiono per difendere la propria purezza,
come
santa Maria Goretti. La fede in Cristo è il presupposto
indispensabile per ogni autentico martirio
cristiano, ma non sempre e necessariamente il motivo
immediato di esso.
2. Due forme di persecuzione: l'uccisione
e l'emarginazione
La persecuzione dei discepoli di Cristo può assumere due forme diverse
che oggi è importante saper riconoscere.
Esse sono descritte in modo paradigmatico e profetico nel capitolo 13
dell'Apocalisse con l'immagine delle due
bestie:
la bestia che sale dal mare (Ap
13,1-10)
e la bestia che sale dalla terra (Ap 13,11-18).
La bestia che sale dal mare è identificata con il potere
politico che si pone al posto di Dio stesso e «fa guerra
contro i santi e li vince», condannando alcuni alla prigione, altri alla
spada.
La «seconda bestia», quella che sale dalla terra,
perseguita anch'essa i santi, ma in modo diverso: in
genere, non mette a morte, ma emargina, ostracizza. Il
suo compito è di «costringere gli abitanti della terra
ad adorare la prima bestia» (Ap 13,11 ss). È un potere
di persuasione occulta, una specie di ministero di propaganda
del Drago. Spinge ad adorare la prima bestia
e ad esserne succubi, inaugurando a tal fine la terribile pratica del marchio
sulla mano e sulla fronte, senza il
quale non è possibile «comprare o vendere», cioè
far parte della società (triste precedente della stella di David imposta
agli ebrei dai nazisti). La seconda bestia
non usa di preferenza le armi, ma la cultura e l'opinione pubblica.
La descrizione dell'Apocalisse ha un'evidente
dimensione storica.
La prima bestia viene quasi unanimemente
identificata con l'impero romano e i suoi
rappresentanti; in particolare con Domiziano, che ha
ufficializzato il culto
divino dell'imperatore, e Nerone, autore
della prima persecuzione ufficiale contro i cristiani.
La seconda bestia sta per l'apparato religioso
e culturale che, specie in Asia Minore, si fa promotore dell'ideologia
imperiale.
Ma la descrizione ha anche una evidente
dimensione profetica:
traccia il quadro di quella che sarà la
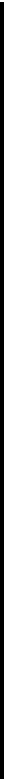 condizione
dei discepoli dell'Agnello in ogni epoca
della
storia. È errato cercare per le descrizioni dell'Apocalisse,
in particolare per quella delle due bestie, riscontri
puntuali in eventi e realtà della storia come
spesso si è fatto, traendone conclusioni aberranti. Sarebbe
però ugualmente stolto non servirsi di questa
denuncia profetica per illuminare le situazioni posteriori
della Chiesa e del mondo. condizione
dei discepoli dell'Agnello in ogni epoca
della
storia. È errato cercare per le descrizioni dell'Apocalisse,
in particolare per quella delle due bestie, riscontri
puntuali in eventi e realtà della storia come
spesso si è fatto, traendone conclusioni aberranti. Sarebbe
però ugualmente stolto non servirsi di questa
denuncia profetica per illuminare le situazioni posteriori
della Chiesa e del mondo.
La cosa è particolarmente evidente ai nostri giorni.
Caduti i regimi totalitari atei e le dittature militari
che incarnavano la prima bestia e hanno fatto tanti
martiri nel secolo appena concluso, è la seconda bestia, al presente, al tenere
il campo.
Papa Benedetto XVI sembra applicare il paradigma delle due bestie
alla situazione attuale quando, nel già
ricordato Messaggio per la
giornata mondiale della pace del 2007,
scrive:
«Vi sono regimi che impongono a tutti un'unica religione, mentre regimi indifferenti alimentano non una
persecuzione violenta, ma un sistematico dileggio culturale nei confronti delle credenze religiose» (n. 3).
Non sono certo terminate del tutto le persecuzioni
cruente; quasi ogni giorno giungono notizie di cristiani
messi a morte o costretti all'esilio da frange estremiste,
nei paesi islamici.
Cosa singolare, è stato proprio un giornalista di fede
islamica, Magdi Allen, a lanciare
recentemente in Italia il movimento «Salviamo i cristiani», per scuotere l'opinione pubblica, stranamente
inerte di fronte a questo problema.
Nel nostro mondo occidentale secolarizzato non è,
tuttavia,
questa la forma abituale che riveste la
persecuzione, ma la seconda, quella che si serve dell'opinione, non
della spada.
L'esegeta Heinrich Schlier ha fatto un'analisi penetrante di questo fatto, commentando il versetto della
Scrittura che parla del «principe delle potenze dell'aria»
(Ef 2,2). Egli attira l'attenzione sul ruolo che svolge, a questo proposito,
l'opinione pubblica. Lo «spirito del
mondo», come lo chiama Paolo (1Cor
2,12), o lo spirito dei tempi, diventa un'atmosfera spirituale attraverso la quale le potenze demoniache agiscono,
come da dietro le quinte.
«Si determina uno spirito di grande intensità storica, a
cui il singolo difficilmente può sottrarsi. Ci si attiene allo spirito
generale, lo si reputa ovvio. Agire o pensare o dire qualcosa contro di esso è
considerato cosa insensata o addirittura un'ingiustizia o un delitto. Allora non
si osa
più porsi di fronte alle cose e alle
situazioni e soprattutto
alla vita in modo diverso da come esso le presenta. Il
dominatore nascosto di questo mondo -
nascosto proprio nell'aria spirituale, nell'atmosfera delle varie epoche - fa apparire il mondo e l'esistenza nella sua propria
prospettiva».
La qualifica di potenze «dell'aria» è particolarmente pertinente, dal momento che questa ideologia ha
oggi il suo veicolo privilegiato nei mezzi di comunicazione di massa che trasmettono i loro messaggi attraverso
l'etere: radio, televisione, internet...
Qual è la differenza tra le due forme di persecuzione?
L'ateismo di stato lotta apertamente contro la fe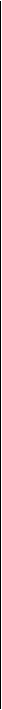 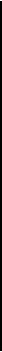 de, de,
il secolarismo tende a farla apparire irrilevante, o
addirittura un residuo di stadi superati dalla coscienza
umana.
«La fede religiosa - si legge in uno di questi
saggi - è inestirpabile, perché siamo creature ancora
in evoluzione. Non si estinguerà mai, o almeno non si
estinguerà finché non vinceremo la paura della morte,
del buio, dell'ignoto e degli altri».
Si prevede che la religione sopravvivrà anche al
presente attacco, come è sopravvissuta ad infiniti altri
che l'hanno preceduto, e ci si preoccupa di dare una spiegazione di questo fatto
imbarazzante, facendo di essa un prodotto
provvisorio, legato alla presente condizione dell'uomo, «essere in
evoluzione». In questo modo, l'intellettuale ateo assume tacitamente il ruolo
di chi ha infranto solitariamente tale
legge, anticipando la fine
dell'evoluzione e, al pari del Zaratustra
nietzschiano, torna sulla terra per illuminare
sulla realtà delle cose i poveri
mortali.
3. Che cosa fa il vero martire: l'amore, l'umiltà e
la grazia
Non ogni perseguitato rientra nella categoria di coloro
che Gesù proclama beati.
La condizione fondamentale è che non ci sia alcuna commistione di ruoli
tra perseguitato e persecutore.
Un terribile caso di scambio di ruoli tra perseguitati
e persecutori è stato, per esempio, l'atteggiamento dei
cristiani verso gli ebrei nel corso dei secoli.
Anche gli
ebrei sono stati odiati dagli uomini, messi al
bando,
insultati e respinti «a causa del Figlio
dell'uomo», ma
in un senso ben diverso da quello inteso e
approvato
da Cristo.
Quando la distinzione dei due ruoli viene meno o è
offuscata, si hanno i casi aberranti dei martiri suicidi
od omicidi: il perseguitato, o uno che si
crede tale, si trasforma in persecutore, il martire in carnefice.
Non sta a noi cristiani giudicare la
concezione del martirio in atto presso altre religioni, ma dobbiamo dire
con chiarezza chi è il vero perseguitato
secondo il vangelo.
Gesù ha raccomandato ai suoi discepoli di essere «come agnelli in mezzo a lupi».
Ha detto loro:
«Quando vi perseguiteranno in una città
fuggite in
un'altra» (Mt 10,23).
I Padri hanno fondato su questa
parola
il rifiuto di ogni atteggiamento di resistenza
violenta, difendendo, all'occasione, anche la fuga davanti
alla persecuzione.
Una forma di confusione tra i ruoli è anche il martirio-provocazione, in cui è il martire a suscitare la
persecuzione con il suo atteggiamento di sfida.
Oggi
non troveremmo più accettabile, per esempio, l'agire dei primi
martiri francescani che, sbarcati in Marocco, si mettono a predicare la fede in
piazza, chiedendo pubblicamente ai saraceni
della città, capi e popolo, di
abbandonare le loro credenze e convertirsi al
cristianesimo.
Già san Francesco si rese conto di ciò perché, pur
elogiando tali martiri come «veri frati minori» per il
 loro
coraggio e la loro buona fede, egli prospettò un
modo diverso di andare
verso «i saraceni e gli altri infedeli», oltre a quello di proclamare
apertamente la fede cristiana ed esortarli alla conversione quando le
circostanze lo permettessero. loro
coraggio e la loro buona fede, egli prospettò un
modo diverso di andare
verso «i saraceni e gli altri infedeli», oltre a quello di proclamare
apertamente la fede cristiana ed esortarli alla conversione quando le
circostanze lo permettessero.
Questo secondo modo, spiega nella primitiva
regola, consiste «nel non fare liti o
dispute, ma nell'essere soggetti ad ogni creatura
umana per amore di Dio, pur confessando di
essere cristiani».
Sollecitato dalla polemica con i Donatisti che giustificavano il martirio-suicidio, sant'Agostino ha riflettuto a lungo sulla vera natura del martirio cristiano
giungendo alla conclusione che «non la pena, ma la
causa fa il martire».
Da sola, questa massima potrebbe portare, anch'essa, a interpretazioni
errate. Tanti sono morti per una
causa
sbagliata, perfino iniqua, credendola buona. Ecco
perché Agostino sente il bisogno di precisare e
completare questa definizione. Non basta neppure
morire per Cristo, per la fede, se lo si fa senza amore,
per polemica contro qualcuno. Richiamandosi al detto
di Paolo: «Se anche dessi il mio corpo per esser bruciato,
ma non avessi la carità, niente mi giova» (1Cor
13,3), Agostino pone come criterio di riconoscimento
del vero martire
l'amore, e in particolare, nel caso dei
Donatisti scismatici, l'amore per l'unità della Chiesa.
È l'amore e il perdono con cui sono morti Cristo, Stefano
e tanti altri dopo di loro il segno di riconoscimento
del vero martire cristiano.
La massima: «La
causa fa il martire» è integrata dall'altra:
«La carità fa
il martire».
È
commovente ritrovare tanti secoli dopo, in
quella
stessa Africa settentrionale in cui aveva
operato Agostino, una delle più luminose testimonianze
di questo martirio accompagnato da amore.
Parlo dei sette monaci trappisti trucidati nel maggio del 1996 a Tibhirine, in Algeria, da un gruppo di
fondamentalisti islamici.
Pochi giorni prima, quando la tragica fine era una
possibilità sempre più incombente, il priore Dom
Christian de Chergé aveva scritto un testamento spirituale che resterà
come una delle espressioni più sublimi
della spiritualità cristiana del martirio:
«Venuto quel momento, vorrei avere quell'attimo di
lucidità che mi permettesse di chiedere il
perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità, perdonando con
tutto il cuore, nello stesso momento, a chi mi avesse
colpito».
Egli non vuole che della eventuale morte, sua e dei
confratelli, venga incolpato tutto l'Islam o il popolo
algerino; non vuole neppure che la colpa
ricada sull'esecutore materiale di essa, «soprattutto se egli dice
di agire in fedeltà a ciò che crede essere
l'Islam».
E conclude, rivolgendosi direttamente a colui che forse
un giorno si troverà davanti con un pugnale:
«E anche a te, amico dell'ultimo istante, che non saprai
quello che starai facendo, sì, anche a te io voglio
dire questo GRAZIE, e questo AD-DIO, nel cui
volto ti 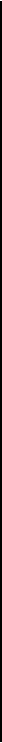 contemplo.
E che ci sia dato di incontrarci di nuovo,
ladroni colmati di gioia, in paradiso, se piace a Dio,
Padre
nostro, Padre di tutti e due. Amen». contemplo.
E che ci sia dato di incontrarci di nuovo,
ladroni colmati di gioia, in paradiso, se piace a Dio,
Padre
nostro, Padre di tutti e due. Amen».
Le circostanze porteranno Agostino a mettere in luce una seconda qualità
essenziale del martirio cristiano, l'umiltà: si tratta del confronto che egli
svolge, nel De civitate Dei, con la cultura pagana che esaltava i
propri martiri e suicidi per onore: Lucrezia, Catone,
Muzio Scevola, Attilio Regolo.
Secondo Agostino, essi hanno dato
prova di orgoglio, non di vera grandezza
d'animo. Questa avrebbe dovuto spingerli a sopportare
con fortezza d'animo la sventura e anche l'umiliazione,
piuttosto che sottrarsi ad esse togliendosi la vita.
L'umiltà dei martiri si manifesta anche nella loro
paura e ripugnanza di fronte alla morte: «Sono martiri, ma prima ancora uomini». Siamo lontanissimi
dallo spirito del saggio stoico, sicuro che, se anche il mondo intero gli
crollasse addosso, egli rimarrebbe
impavido
tra le rovine.
Il martire cristiano non affronterà
mai la prova fidando sulle proprie forze, ma unicamente sulla grazia di Dio.
Nella polemica contro i Pelagiani, la celebre affermazione di Agostino:
«La
causa fa il martire» si arricchirà di un'altra
verità: «La grazia fa il martire».
Alla luce di questi approfondimenti appaiono ingenui e anacronistici
certi accostamenti tra gli atteggiamenti
del martire e quelli dell'eroe pagano di tanta
letteratura martirologica.
Se fosse storica (ma non lo
è) la
frase: «Questa parte è cotta, volta e mangia», rivolta dal diacono Lorenzo al
carnefice dalla graticola
ardente, lo
accosterebbe più a Muzio Scevola che
non a Gesù Cristo.
In questo senso appare profondamente agostiniano
e cristiano il modo in cui la preparazione al martirio è
presentata da Bernanos nei Dialoghi delle carmelitane e prima di
lui da Gertrud von le Fort nel racconto
L'ultima al patibolo.
La giovane suor Bianca dell'Agonia di Gesù è
presa da terrore davanti alla prospettiva
del martirio e fugge separandosi dalle consorelle;
all'ultimo momento, però, trova la forza di presentarsi
da sola e salire sulla ghigliottina cantando
l'ultima strofa del
Veni creator.
Come Gesù che agonizza davanti
all'imminente passione ed esclama: «Lo spirito
è pronto, ma la carne è debole», ma poi dice agli altri risolutamente:
«Alzatevi, andiamo» (Mt 26,41.46).
Anche il dramma Assassinio nella cattedrale di
Thomas S. Eliot costituisce una splendida riflessione
sul martirio cristiano. Per lui l'ultima tentazione che il
martire deve affrontare è quella dell'orgoglio. Le insinuazioni del Tentatore a Tommaso Becket sono: «Che
cosa può paragonarsi alla gloria dei santi? Quale gloria terrena, di re o imperatore? Cercate la via del martirio, fatevi il più basso in terra, per essere alto nel
cielo...». Ma le ultime parole dell'arcivescovo al suo
popolo, prima che giungano i sicari del re, sono: «II
martirio cristiano non è l'effetto della volontà di un
uomo di diventare santo... Un martire, un
santo è fatto sempre dal disegno di
Dio, per il suo amore per gli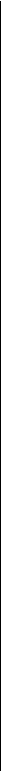 uomini...
Il martire non desidera più nulla per se stesso, neppure la gloria del martirio». uomini...
Il martire non desidera più nulla per se stesso, neppure la gloria del martirio».
Il martirio è grazia.
4. Perseguitati ingiustamente o giustamente?
Nel suo estesissimo commento alle beatitudini,
l'esegeta J. Dupont dà grande rilievo a un inciso che
si legge nella versione di Matteo: «Beati voi quando
vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa
mia».
Secondo lui l'inciso «mentendo»
riflette la preoccupazione
dell'evangelista di distinguere la
persecuzione ingiusta dalla persecuzione
giusta.
Forse spinto dalla sua esperienza ecclesiale, l'evangelista prospetta la
possibilità che i cristiani non siano
accusati a torto, ma a ragione, non mentendo, ma dicendo il vero.
Non è, del resto, una voce isolata nella
Chiesa apostolica.
San Pietro distingueva già tra il
soffrire perché cristiano e il soffrire perché «omicida,
ladro o malfattore» (lPt
4,15-16), e anche san Paolo esorta spesso i
credenti a non dare motivo ai pagani di
biasimarli con il loro comportamento.
I primi predicatori cristiani prospettano anch'essi la
possibilità che la persecuzione possa essere determinata dalla condotta incoerente dei cristiani, e non da
semplice odio del nome.
«Quando i pagani - scriveva
un
autore anonimo del II secolo - sentono dalla nostra
bocca le parole di Dio, ne ammirano la bellezza e la grandezza; ma poi, quando
osservano che le nostre
opere non corrispondono alle parole che
diciamo, cominciano a bestemmiare il nome di Dio».
Mai come in questo caso le beatitudini ci appaiono
come l'autoritratto di Gesù, colui nel quale
esse si sono pienamente ed esemplarmente compiute.
C'è uno solo, ha scritto il filosofo
Kierkegaard, che è stato
perseguitato
davvero e solo ingiustamente: Gesù Cristo.
Noi tutti quando siamo perseguitati e soffriamo,
dobbiamo unirci al buon ladrone sulla croce e dire:
«Noi soffriamo giustamente, perché riceviamo il giusto
per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male» (Lc 23,41).
Se non abbiamo commesso la particolare colpa
che ci viene imputata, non siamo
mai
però del tutto esenti da colpa.
Solo Dio, se soffre,
soffre in assoluto da innocente.
Fa forse eccezione la sofferenza dei bambini
innocenti, e proprio per
questo
facciamo tanto fatica ad accettarla.
Essa fa
massa con quella dell'Agnello senza macchia ed
è
l'unico pensiero che può salvare il credente
dalla disperazione.
Tutto ciò deve aiutare i credenti a non cadere in
inutili complessi di persecuzione di fronte alla crescente ostilità del mondo secolarizzato verso di essi.
Tale ostilità non è mai senza qualche motivo.
Anche oggi, come al tempo dell'anonimo
autore della Seconda Lettera
di Clemente, molti uomini ammirano
la bellezza di Cristo e la verità del vangelo, ma sono
scandalizzati dal l'incoerenza di coloro che
si professano cristiani.
  L'atteggiamento
ideale del cristiano nei confronti
delle
opposizioni del mondo è tracciato da san Paolo
quando scrive:
«Insultati, benediciamo; perseguitati,
sopportiamo; calunniati, confortiamo» (1Cor 4,12-13);
un programma che l'autore della Lettera a Diogneto
vedeva realizzato nei cristiani del suo tempo
che, come egli scrive, «amano tutti, e vengono da tutti perseguitati,
sono ingiuriati e benedicono». L'atteggiamento
ideale del cristiano nei confronti
delle
opposizioni del mondo è tracciato da san Paolo
quando scrive:
«Insultati, benediciamo; perseguitati,
sopportiamo; calunniati, confortiamo» (1Cor 4,12-13);
un programma che l'autore della Lettera a Diogneto
vedeva realizzato nei cristiani del suo tempo
che, come egli scrive, «amano tutti, e vengono da tutti perseguitati,
sono ingiuriati e benedicono».
La beatitudine dei perseguitati per la giustizia non
va vissuta, del resto, solo nelle grandi occasioni o nello
scontro tra la Chiesa e il mondo, ma anche nelle
occasioni quotidiane, nei contrasti e
opposizioni che la vita riserva a tutti.
Spesso la «giustizia», cioè il dovere e
la coscienza, costringono a dire e fare cose che
possono suscitare opposizione intorno a noi, anche
nella cerchia più ristretta
della propria casa, avverte Gesù: «Si
divideranno tre contro due e due contro tre;
padre contro figlio e figlio contro padre,
madre contro figlia e figlia contro
madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera» (Lc 12,53).
Anche all'interno
della Chiesa.
5. Prima di scendere dal monte
Giunti alla fine delle nostre riflessioni sulle beatitudini, vorrei soffermarmi ancora un momento e abbracciarle tutte con uno sguardo d'insieme. Tempo fa,
il comune di Brescia ha organizzato un ciclo di conferenze
pubbliche sulle beatitudini, chiamando a commentarle
personaggi della cultura, della finanza e della politica.
A me fu assegnata la beatitudine dei puri di
cuore, allo scrittore Erri De Luca la beatitudine dei
poveri di spirito.
Egli diede, delle beatitudini, un giudizio
che trovo efficacissimo:
«I valori sono rovesciati. La serie successiva delle letizie nuove è
messa a contrappunto delle misere gerarchie
terrestri. Lieti sono i mansueti, gli affamati, gli assetati
di giustizia, i misericordiosi. La novità è uno scardinamento. Queste
letizie scottano come un tizzone da afferrare con le mani... Mai sono state così
sconvolte le classifiche ufficiali, i
ranghi, a opera non di un'insurrezione,
ma sotto la spinta di una letizia sconosciuta ai potenti... La sua novità
non ha trovato ancora posto in terra».
Ci sarebbe forse qualcosa da precisare circa l'ultima affermazione.
Gesù diceva: «Il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione,
e nessuno dirà:
Eccolo qui, o:
eccolo là. Perché il regno di Dio è in mezzo a voi!» (Lc 17,21).
Questo vale in modo particolare per le beatitudini.
Esse si realizzano già, almeno in
parte, in questo mondo, ma non nel modo con
cui
«il mondo» si aspetterebbe. Non si contano i cuori
umani
che, già in questa vita, hanno sperimentato la
felicità promessa da Cristo ai poveri, ai miti, ai puri di
cuore.
Fin d'ora - fa notare san Tommaso d'Aquino -
gli afflitti sono consolati dallo Spirito Santo che è chiamato Paraclito,
cioè consolatore; gli affamati sono saziati
con il pane della vita, i misericordiosi ricevono misericordia, quelli che si purificano dal male
vedono in qualche modo Dio e quelli che
dominano i moti dell'ira sono chiamati
figli di Dio.
Ma questo non dà ragione di tutto; è un compimento riservato a pochi,
che lascia insoddisfatti quelli che
si affliggono per la
povertà, la fame e le ingiustizie
subite da
intere masse umane.
In questo senso si comprende
l'esclamazione dell'amico De Luca: «La novità delle
beatitudini non ha ancora trovato posto in terra».
Verrebbe da esclamare, a proposito delle beatitudini,
ciò che la Giovanna d'Arco di Péguy dice commentando
il Padre nostro: «Padre nostro, come è lontano il tuo regno
dall'arrivare. Come è lontana la tua volontà
dall'essere fatta!». Come sono lontani, o
Dio, gli affamati dall'essere saziati, gli afflitti dall'essere
consolati, i miti dal possedere la terra!
La soluzione sta altrove.
Per capire le beatitudini,
bisogna partire
dall'apodosi, cioè dalla promessa legata a ognuna di esse.
Questa è quasi sempre al futuro, rimanda a un'altra esistenza: Beati gli
afflitti «perché saranno consolati», i miti «perché erediteranno la terra», gli affamati «perché saranno saziati», i misericordiosi «perché troveranno misericordia», i puri di cuore
«perché vedranno Dio», gli operatori di pace «perché saranno chiamati
figli di Dio» e, infine, i perseguitati per la giustizia «perché di essi è il
regno dei cieli».
L'ostacolo maggiore alla comprensione delle beatitudini, come della fede
in genere, dipende dalla caduta
dell'orizzonte dell'eternità.
Sulla parola «eternità»
è caduto dapprima
il sospetto marxista secondo cui
essa aliena
dall'impegno storico per trasformare il
mondo e migliorare
la vita presente, è un'evasione
dalla realtà.
Il materialismo e il consumismo dilagante
hanno fatto il resto, facendo apparire perfino strano e quasi
sconveniente che si parli ancora di eternità tra persone "moderne", al passo coi
tempi.
Eppure sotto questa coltre di oblio c'è in tutti una
segreta nostalgia di eternità.
L'uomo, dicono i filosofi,
è «un
essere finito, capace di infinito», e, proprio per questo, perché capace di
infinito, desideroso di esso,
bisognoso di esso.
Alcuni non credenti ritengono presuntuoso aspettarsi una vita eterna; dicono: bisogna accontentarsi di
questa vita e lasciare serenamente il mondo ai figli e a
coloro che verranno dopo di noi. Io non metto in dubbio la loro sincerità, ma faccio difficoltà a credere che
questo pensiero li renda davvero contenti e soddisfatti.
Il filosofo Miguel de Unamuno (che pure era un
pensatore "laico") rispondeva in questi termini a un
amico che gli rimproverava, quasi fosse orgoglio e
presunzione, la sua ricerca di eternità:
«Non dico che meritiamo un aldilà, né che la logica ce
lo dimostri, dico che ne abbiamo bisogno, lo meritiamo o
no, e basta. Dico che ciò che passa non mi soddisfa, che
ho sete d'eternità, e che senza questa tutto mi è indifferente. Senza di
essa non c'è più gioia di vivere... è
troppo facile affermare: "Bisogna vivere, bisogna accontentarsi di
questa vita". E quelli che non se ne accontentano?».
Non è chi desidera l'eternità, aggiungeva lo stesso
pensatore, che mostra di non amare la vita, ma chi
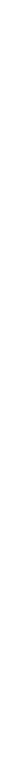 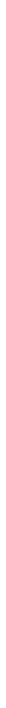 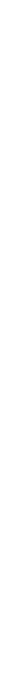 non la desidera, visto che
si rassegna così facilmente al pensiero che essa debba finire. non la desidera, visto che
si rassegna così facilmente al pensiero che essa debba finire.
Sant'Agostino aveva espresso lo stesso
pensiero quando scriveva: «A che
serve vivere bene, se non ci è dato di vivere sempre?».
Se si nega l'eterno nell'uomo, allora si deve
esclamare subito, come fece il Macbeth di
Shakespeare dopo aver ucciso il re: «Non vi è più nulla di serio
nella vita mortale, tutto è gioco: la gloria
e l'onore sono morti; il vino della
vita è versato».
Ogni anno si tiene a Rimini un incontro nazionale
del movimento del Rinnovamento nello Spirito
al quale sono invitato spesso a parlare.
Un anno mi sentii ispirato a parlare dell'eternità e lo feci, credo, con
grande convinzione ed entusiasmo. Volevo
risuscitare
questa parola morta e ogni tanto invitavo la
folla (c'erano oltre 50.000 persone) a ripetere con me il grido:
«Eternità, eternità!». Sembrava di essere sulla caravella
di Cristoforo Colombo quando - dopo che ogni
speranza stava per essere abbandonata - si udì un
mattino la sentinella gridare: «Terra, terra!».
Fu tale l'entusiasmo che in seguito a ciò qualcuno
fece stampare degli sticker, gli
adesivi che si mettono sui vetri delle auto. Su uno c'era una «I», che in inglese
significa «io», con un cuore rosso che sta per
«amo» seguito dalla parola eternity, «eternità»; su un
altro c'era il verso del poeta credente: «Tutto tranne
l'eterno al mondo è vano».
È vero che «la verità delle beatitudini non ha trovato
ancora posto in terra», almeno non come noi vorremmo, ma Gesù non le ha pronunciate invano se esse ci aiutano a tener
desto, nel tempo, l'anelito all'eternità.
PER UN ESAME DI COSCIENZA BASATO SULLE
BEATITUDINI
«Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli».
Sono pronto a soffrire
qualcosa in
silenzio per il vangelo?
Come reagisco
davanti a qualche torto o sgarbo che ricevo?
Partecipo
intimamente alle sofferenze dei tanti
fratelli che soffrono davvero per la fede, o per la giustizia
sociale e
la libertà?
|
Beati i perseguitati