|
Meditazione n. 7
«BEATI GLI OPERATORI DI PACE,
PERCHÉ SARANNO CHIAMATI FIGLI DI DIO»
1. Chi sono gli operatori di pace
La settima beatitudine suona così: «Beati gli operatori
di pace, perché saranno chiamati figli di Dio».
Insieme
con quella dei misericordiosi, questa è l’unica beatitudine che non dice tanto
come bisogna "essere"
(poveri, afflitti, miti, puri di cuore), quanto cosa si deve
"fare".
Il termine eirenopoioi significa coloro che
lavorano per la pace, che «fanno pace».
Non tanto,
però, nel senso che si riconciliano con i propri nemici,
quanto nel senso che aiutano i nemici a riconciliarsi.
«Si tratta di persone che amano molto la pace, tanto
da non temere di compromettere la propria pace personale
intervenendo nei conflitti al fine di procurare
la pace tra quanti sono divisi».
Operatori di pace non è dunque sinonimo di
pacifici,
cioè di persone tranquille e calme che evitano il più possibile i
contrasti (questi sono proclamati beati da
un'altra
beatitudine, quella dei miti); non è sinonimo
neppure di pacifisti, se per
pacifisti si intendono quelli che si schierano contro la guerra (più spesso, contro
uno dei contendenti in guerra!), senza fare
nulla per riconciliare tra loro i contendenti. Il termine più giusto
è pacificatori.
Al tempo del Nuovo Testamento, pacificatori erano
detti i sovrani, soprattutto l'imperatore romano.
Augusto
metteva in cima alle proprie imprese quella di
aver stabilito nel mondo la pace, mediante le
sue vittorie
militari e a Roma fece erigere la famosa Ara pacis, l'altare della pace.
Qualcuno ha pensato che la beatitudine evangelica
intenda
opporsi a questa pretesa, dicendo chi sono i
veri operatori della pace e in che modo essa viene
promossa: mediante vittorie, sì, ma vittorie su se stessi,
non sui nemici, non distruggendo il nemico, ma distruggendo
l'inimicizia, come fece Gesù sulla croce
(Ef 2,16).
Oggi prevale però l'opinione che la beatitudine vada letta
tenendo conto della Bibbia e delle fonti giudaiche, in cui aiutare persone in
discordia a riconciliarsi
e a vivere in pace è visto come una delle principali opere di misericordia.
Sulla bocca di Cristo
la beatitudine degli operatori di pace discende dal comandamento
nuovo dell'amore fraterno, è una modalità
in cui si esprime l'amore del prossimo.
Sorprende ascoltare dalla stessa bocca di Cristo
un'affermazione che sembra contraddire tutto questo: «Pensate che
io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione» (Lc
12,51).
In Matteo,
al posto di divisione c'è addirittura «la spada»
(Mt
10,34).
Ma non
c'è vera contraddizione.
Si
tratta di vedere qual è la pace e l'unità che
Gesù è venuto a portare, e qual è la pace e l'unità che è venuto a togliere.
Egli è venuto a portare la pace e l'unità nel bene,
quella che conduce alla vita eterna, ed è venuto a
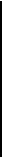 togliere
quella falsa pace e unità che serve solo ad addormentare le coscienze e a
portare alla rovina. togliere
quella falsa pace e unità che serve solo ad addormentare le coscienze e a
portare alla rovina.
Gesù non è venuto con l'intenzione di portare la divisione e la
guerra; tuttavia, dalla sua venuta risulterà
inevitabilmente divisione e contrasto, perché egli mette
le persone davanti alla decisione e, davanti alla necessità
di decidersi, si sa che la libertà umana reagirà
in modo diverso e variegato.
La sua parola e la sua
stessa persona fanno venire a galla quello che ognuno
nasconde nel proprio cuore.
Il vecchio Simeone lo
aveva predetto, prendendo in braccio il bambino Gesù:
«Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti
in Israele, segno di contraddizione perché
siano svelati i pensieri di molti cuori» (Lc 2,35).
La prima
vittima di questa contraddizione, il primo a
soffrire della «spada» che egli è venuto a portare sulla terra, sarà
proprio lui, che in
questo contrasto ci rimetterà la vita.
2. Il messaggio per la giornata mondiale della pace
Si direbbe che quella degli operatori di pace è per
eccellenza la beatitudine della Chiesa di Roma e del
suo Vescovo.
Uno dei servizi più preziosi resi alla cristianità dal papato,
nei suoi momenti migliori, è stato
quello di promuovere la pace tra le diverse chiese e,
in certe epoche, anche tra i principi cristiani.
La prima lettera apostolica di un papa, quella di san Clemente I,
risalente al 96 circa dopo Cristo (prima ancora, forse,
del Quarto Vangelo), fu scritta per riportare la pace
nella Chiesa di Corinto
dilaniata da discordie.
La storia della Chiesa è ricca di episodi in cui chiese
locali, vescovi o abati in lite tra di loro o con il proprio gregge sono ricorsi
al papa come arbitro di pace.
Sono sicuro che questo è tuttora uno dei servizi più
frequenti resi alla Chiesa universale, anche se uno dei
meno conosciuti.
Anche la diplomazia vaticana e i
nunzi apostolici trovano la loro giustificazione nell'essere
strumenti a servizio della pace.
È un servizio
che non si può rendere senza un qualche potere reale
di giurisdizione. Per rendersi conto della sua preziosità
basta guardare le difficoltà che sorgono là dove esso
è assente.
Da qualche tempo il servizio del papa nei confronti
della pace si esprime anche attraverso il messaggio per la
giornata mondiale della pace diffuso all'inizio
di ogni nuovo anno.
Io vorrei partire proprio dal messaggio
per l'anno 2007 per una riflessione sulla
nostra beatitudine.
Si tratta di un messaggio sulla pace
a tutto campo; spazia dall'ambito personale a quelli
più vasti della politica, dell'economia, dell'ecologia,
degli organismi internazionali. Ambiti diversi, ma
unificati dal fatto di avere tutti come oggetto primario
la persona umana, da cui il titolo del messaggio: «La
persona umana, cuore della pace».
C'è nel messaggio un'affermazione fondamentale,
che è come la chiave di lettura di tutto; dice:
«La
pace è insieme un dono e un compito.
Se è
vero che la pace tra gli individui ed i popoli - la capacità di
vivere gli uni accanto agli altri tessendo
rapporti di giustizia e di solidarietà - rappresenta un impegno che non
conosce sosta, è anche vero, lo è anzi di
più, che la pace è dono di
Dio. La pace
è, infatti, una caratteristica del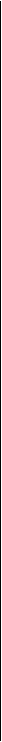 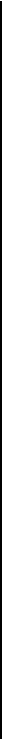 l'agire
divino, che si manifesta sia nella creazione di un universo ordinato e armonioso
come anche nella redenzione
dell'umanità bisognosa di essere recuperata dal
disordine del peccato. Creazione e redenzione offrono
dunque la chiave di lettura che introduce alla comprensione
del senso della nostra esistenza sulla terra»
(Benedetto XVI, «La persona umana, cuore della pace». Messaggio
per la Giornata
mondiale della pace 2007). l'agire
divino, che si manifesta sia nella creazione di un universo ordinato e armonioso
come anche nella redenzione
dell'umanità bisognosa di essere recuperata dal
disordine del peccato. Creazione e redenzione offrono
dunque la chiave di lettura che introduce alla comprensione
del senso della nostra esistenza sulla terra»
(Benedetto XVI, «La persona umana, cuore della pace». Messaggio
per la Giornata
mondiale della pace 2007).
Queste parole aiutano a capire la beatitudine degli
operatori di pace, e questa, a sua volta, getta una luce
singolare su queste parole. Mediteremo sulla pace come
dono e compito.
3. La pace come dono
Dio stesso, non un uomo, è il vero e supremo «operatore
di pace».
Proprio per questo, quelli che si adoperano per la pace sono
chiamati «figli di Dio»: perché somigliano a lui, imitano lui, fanno quello che
fa lui.
Il messaggio pontificio dice che la pace è caratteristica
dell'agire divino nella creazione e nella redenzione,
cioè sia nell'agire di Dio che in quello di Cristo.
La Scrittura parla della «pace di Dio» (Fil 4,7) e più
spesso ancora del «Dio della pace» (Rm 15,32).
Pace
non indica solo ciò che Dio fa o dà, ma anche ciò
che
Dio è.
Pace è ciò che regna in Dio.
Quasi tutte le religioni
fiorite intorno alla Bibbia conoscono mondi divini
in guerra al loro interno.
I miti cosmogonici babilonesi
e greci parlano di divinità che si fanno guerra
tra loro.
Nella stessa gnosi eretica cristiana non c'è
unità e pace tra gli Eoni celesti, e l'esistenza del mondo
materiale non è che il risultato di un incidente e di una disarmonia occorsi nel
mondo superiore.
Su questo sfondo religioso si può meglio cogliere
la
novità e l'alterità assoluta della dottrina della Trinità
come perfetta unità d'amore nella pluralità delle persone.
In un
suo inno, la Chiesa chiama la Trinità «oceano di pace», e non è solo una frase
poetica.
Ciò
che più colpisce contemplando l'icona della
Trinità di Rublèv è il senso di
sovrumana pace che emana
da essa.
Il pittore è riuscito a tradurre in un'immagine
il motto di san Sergio di Radonez, per il cui monastero
fu dipinta l'icona: «Contemplando la Santissima
Trinità, vincere l'odiosa discordia di questo
mondo».
Chi ha meglio celebrato questa Pace divina che viene
da oltre la storia è stato lo Pseudo Dionigi Areopagita.
Pace,
per lui, è uno dei «nomi di Dio», allo stesso
titolo che «amore».
Anche di Cristo è detto che
«è» lui stesso la nostra pace (Ef 2,14-17).
Quando dice: «Vi do la mia pace», egli ci trasmette quello che è.
C'è un nesso inscindibile tra la pace dono dall'alto
e
lo Spirito Santo; non per nulla essi sono rappresentati
dallo stesso simbolo della colomba.
La sera di
Pasqua Gesù diede ai discepoli, quasi d'un sol fiato,
la pace e lo Spirito Santo: «"Pace a voi!"... Detto questo
alitò su di loro e disse: "Ricevete lo Spirito Santo"»
(Gv 20,21-22).
La pace,
dice Paolo, è un «frutto
dello Spirito» (Gal 5,22).
Ma cos'è la pace di cui parliamo?
È divenuta classica
la definizione datane da sant'Agostino: «La pa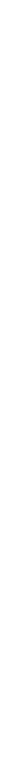 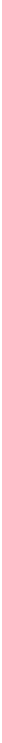 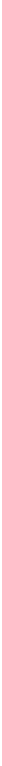 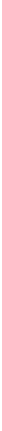 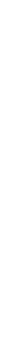 ce
è la tranquillità dell'ordine». ce
è la tranquillità dell'ordine».
Basandosi su di essa,
san Tommaso dice che nell'uomo esistono tre tipi
di ordine: con se stesso, con Dio, e con il
prossimo, ed
esistono, di conseguenza, tre forme di pace:
la pace
interiore, con la quale l'uomo è in pace con se
stesso;
la pace
per cui l'uomo sta in pace con Dio,
assoggettandosi pienamente alle sue disposizioni,
e la pace relativa al prossimo, per cui si vive in pace
con tutti.
Nella Bibbia, però, shalom, pace, dice più che la semplice
tranquillità dell'ordine. Indica anche benessere, riposo, sicurezza, successo,
gloria.
A volte designa,
addirittura, la totalità dei beni messianici ed è sinonimo
di salvezza e di bene:
«Come sono belli sui
monti i piedi del messaggero di lieti annunci che annuncia
la pace, messaggero di bene che annuncia la
salvezza»
(Ts 52,7).
La nuova alleanza è chiamata
un'«alleanza di pace» (Ez 37,26), il vangelo «vangelo
della pace» (Ef 6,15), come se nella parola pace si
riassumesse tutto il contenuto dell'alleanza e del Vangelo.
Nell'Antico Testamento, pace viene spesso accostata a
giustizia (Sal 85,11: «Giustizia e pace si baceranno»)
e nel Nuovo Testamento a grazia.
Quando san Paolo scrive: «Giustificati per mezzo della fede, noi
siamo in pace con Dio» (Rm 5,1), è chiaro che «in pace con Dio»
ha lo stesso significato pregnante che «in grazia di Dio».
4. La pace come compito: la pace religiosa
Il messaggio del Papa dice che la pace, oltre che dono,
è anche compito.
Ed è della pace come compito
che ci parla, in primo luogo, la beatitudine degli operatori di
pace.
Se Dio e, storicamente, il Cristo risorto,
è la sorgente vera della pace cristiana, essere operatore
di pace non significa inventare o creare la pace, ma trasmetterla, lasciar
passare la pace di Dio e la pace di
Cristo «che supera ogni intelligenza».
«Grazia a voi e
pace da Dio, Padre nostro, e dal
Signore Gesù Cristo»
(Rm 1,7): questa è la pace che l'Apostolo trasmette ai
cristiani di Roma.
Noi non possiamo essere sorgenti,
ma solo
canali della pace.
Lo
esprime alla perfezione la preghiera
attribuita a Francesco d'Assisi: «Signore,
fa' di me uno strumento della
tua pace».
La condizione per poter essere canali di pace è rimanere uniti
alla sua sorgente che è la volontà di Dio: «En la sua voluntade è nostra pace»,
fa dire Dante a un'anima del Purgatorio.
Il segreto della pace interiore
è l'abbandono totale e sempre rinnovato
alla
volontà
di Dio.
Aiuta a conservare o ritrovare questa pace
del cuore ripetere spesso a se stessi con santa Teresa
d'Avila: «Niente ti turbi, niente ti spaventi. Tutto passa,
Dio solo resta. La pazienza tutto vince. Nulla manca
a chi ha Dio. Dio solo basta».
La
parenesi apostolica è ricca di indicazioni pratiche
su ciò che favorisce o che ostacola la pace. Uno
dei passi più noti è quello della Lettera di Giacomo:
«Dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e
ogni sorta di cattive azioni. La sapienza che viene dall'alto
invece è anzitutto pura; poi pacifica, mite, arren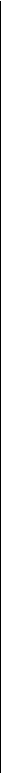 devole,
piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità,
senza ipocrisia. Un frutto di giustizia viene seminato
nella pace per coloro che fanno opera di pace» (Gc
3,16-18). devole,
piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità,
senza ipocrisia. Un frutto di giustizia viene seminato
nella pace per coloro che fanno opera di pace» (Gc
3,16-18).
Da questo ambito personalissimo deve partire ogni
sforzo per costruire la pace.
La pace è come la scia di un bel vascello che va allargandosi
all'infinito, ma comincia con una punta, e la punta è, in questo caso, il
cuore dell'uomo.
Uno dei
messaggi di Giovanni Paolo II per la giornata
della pace, quello del 1984, portava come titolo: «La pace nasce da un cuore nuovo».
Ma non è su questo ambito personale che vorrei dilungarmi.
Oggi si apre davanti agli operatori di pace
un campo
di lavoro nuovo, difficile e urgente: promuovere
la pace tra le religioni e con la religione,
cioè sia delle religioni tra di loro, sia dei credenti delle
varie religioni con il mondo laico non credente.
Il
teologo Hans Kung ha lanciato il seguente slogan ripreso
in sede internazionale dal Parlamento delle religioni
di Chicago nel 1993: «Non c'è pace tra le nazioni
senza pace tra le religioni e non c'è pace tra le religioni senza dialogo tra le
religioni».
Il motivo che permette un dialogo serio tra le religioni
- fondato non solo sulle ragioni di opportunità
che
conosciamo bene, ma su un solido fondamento
teologico - è che «abbiamo tutti un unico Dio», come
ricordava Benedetto XVI in occasione della sua visita
alla Moschea Blu di Istanbul.
È la verità da cui anche san Paolo partì nel suo discorso
all'areopago di Atene
(cfr. At
17,28).
Abbiamo, soggettivamente, idee diverse su di Lui.
Per noi cristiani Dio è «il Padre del Signore nostro
Gesù Cristo» che non si conosce pienamente se non «per mezzo
suo», ma oggettivamente sappiamo bene
che di Dio non ce ne può essere che uno.
C'è «un solo
Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per
mezzo di tutti ed è presente in tutti» (Ef 4,6).
Ogni
popolo e lingua ha il suo nome per indicare il sole, ma
di sole ce n'è uno solo!
Fondamento teologico del dialogo è anche la nostra
fede nello Spirito Santo.
Come
Spirito della redenzione e Spirito della grazia, egli è il vincolo della pace
tra i battezzati delle diverse confessioni cristiane,
ma come Spirito della creazione, Spiritus creator,
egli è un vincolo di pace tra i credenti di
tutte le religioni
e anzi tra tutti gli uomini di buona volontà.
«Ogni verità, da chiunque venga detta - ha scritto
san Tommaso d'Aquino -, viene dallo Spirito
Santo».
Come
però questo Spirito creatore guidava verso
Cristo i profeti dell'Antico Testamento (lPt
1,11),
così noi cristiani crediamo che, in modo
noto solo a Dio, esso guida a Cristo e al suo mistero pasquale
nella sua azione fuori della Chiesa.
Come il
Figlio non fa nulla senza il Padre, così lo Spirito Santo
non fa nulla senza il Figlio.
5. Una pace senza religioni?
L'occidente secolarizzato auspica, a dire il vero, un
diverso tipo di pace religiosa, quello che risulta dalla
scomparsa di ogni religione.
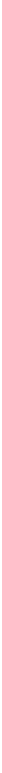 «Immagina
che non esista paradiso, / è facile se provi./
Nessun inferno sotto di noi, / nient'altro
che il cielo su
di noi... / Immagina non ci siano più patrie... nulla per cui uccidere o morire
/ e nessuna religione più. / Immagina tutta la gente / vivere la vita in pace...
Immagina un mondo senza possedimenti...». «Immagina
che non esista paradiso, / è facile se provi./
Nessun inferno sotto di noi, / nient'altro
che il cielo su
di noi... / Immagina non ci siano più patrie... nulla per cui uccidere o morire
/ e nessuna religione più. / Immagina tutta la gente / vivere la vita in pace...
Immagina un mondo senza possedimenti...».
Questa canzone, scritta da uno dei grandi idoli della
musica leggera moderna, John Lennon, su una melodia
suadente, ha qualcosa che fa sognare e spiega
l'immensa popolarità che si è acquistata. Ma pochi si rendono
conto della sua natura tutt'altro che pacifista,
perché, a detta dello stesso autore, l'intento «antireligioso,
antinazionalista e anticonvenzionale è ricoperto
di zucchero».
È davvero auspicabile un mondo in cui non ci siano
più «né religione, né patrie, né proprietà privata»?
Non era esattamente quello che si erano proposti di
realizzare i regimi comunisti totalitari,
sappiamo con che risultato? Tutti saremmo felici se non ci fosse più
al mondo «nulla per cui uccidere»; ma che
dire di un mondo in cui non c'è più «nulla per cui morire»?
Se un tale "sogno" si dovesse realizzare, quello auspicato
sarebbe il mondo più povero e più squallido
che si
possa immaginare; un mondo piatto, in cui sono
abolite tutte le differenze, dove la gente è destinata
a sbranarsi, non a «vivere in pace», perché
- come ha messo in luce Rene Girard -,
laddove tutti vogliono le stesse
cose, il "desiderio mimetico" si scatena, e con esso la rivalità e la
guerra.
Un altro
aveva in precedenza lanciato il programma:
«Non più cielo. Non più inferno!
Nient'altro che la terra» (ed è forse da lui che l'autore della canzone lo
raccoglie); ma lo stesso aveva dovuto
poi constatare che «l'inferno sono gli altri». L'inferno da "sotto di
noi" si sposta "tra noi".
Il messaggio del papa dedica un paragrafo alle difficoltà
che si incontrano oggi nel rapporto tra la religione e il mondo secolarizzato.
Dice:
«Per quanto riguarda poi la libera
espressione della
propria fede,
un altro preoccupante sintomo di mancanza
di pace nel mondo è rappresentato dalle difficoltà che tanto i cristiani quanto
i seguaci di altre religioni incontrano
spesso nel professare pubblicamente e liberamente
le proprie convinzioni religiose... Vi sono regimi che impongono
a tutti un'unica religione, mentre regimi indifferenti
alimentano non una persecuzione violenta, ma un
sistematico dileggio culturale nei confronti delle credenze
religiose. In ogni caso, non viene rispettato un diritto
umano fondamentale, con gravi ripercussioni sulla convivenza
pacifica» (n. 3).
Di questo tentativo di emarginazione delle credenze
religiose, abbiamo un segno nella campagna
messa in atto in vari paesi e città
d'Europa e d'America contro i simboli religiosi del
Natale.
Si adduce come motivo la volontà di non offendere
le persone di altre religioni che sono tra noi,
specie i musulmani.
Ma è un pretesto.
In realtà è un 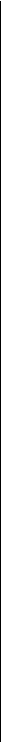 certo
mondo laicista che non vuole questi simboli,
non i musulmani. certo
mondo laicista che non vuole questi simboli,
non i musulmani.
Essi non hanno nulla contro il Natale cristiano, che anzi
onorano.
Nel Corano c'è una Sura dedicata alla nascita di Gesù che
vale la pena di conoscere,
anche per favorire il dialogo e l'amicizia tra
le religioni. Dice:
«Gli angeli dissero: "O Maria, Iddio ti dà la lieta novella
di un Verbo da Lui. Il suo nome sarà Gesù figlio di Maria. Sarà illustre in
questo mondo e nell'altro...
Parlerà agli uomini dalla culla e da uomo maturo,
e sarà
dei Santi". Disse Maria: "Signore mio, come potrò
avere un figlio, quando nessun uomo mi ha toccata?".
Rispose: "Proprio così: Iddio crea ciò che Egli
vuole, e quando ha deciso una cosa, le dice
soltanto 'sii',
ed essa è».
Siamo
giunti all'assurdo che alcuni musulmani celebrano
la nascita di Gesù e arrivano a dire che «non è
musulmano chi non crede nella nascita miracolosa di Gesù», mentre altri
che si dicono cristiani vogliono fare
del Natale una festa invernale popolata solo di
renne e di orsacchiotti.
Noi credenti non possiamo, però, lasciarci andare a
risentimenti e polemiche neanche contro il mondo secolarizzato.
Accanto al dialogo e alla pace tra le religioni,
si pone già un altro traguardo agli operatori di
pace: quello della pace tra i credenti e i non credenti, tra le
persone religiose e il mondo secolare, indifferente
o ostile alla religione.
Dobbiamo dare ragione,
anche con fermezza, della speranza che è in noi, ma farlo - come
esorta la Lettera di Pietro - «con dolcezza
e rispetto» (1Pt 2,15-16).
Rispetto non significa in questo caso «rispetto umano»,
un tener nascosto Gesù per non suscitare reazioni.
È
rispetto di un'interiorità che è nota solo a Dio e
che nessuno può violare o
costringere a cambiare.
Non è un mettere tra parentesi Gesù, ma un mostrare
Gesù e il Vangelo con la vita.
Ci
auguriamo soltanto che un uguale rispetto
sia mostrato dagli altri nei confronti
dei cristiani, ciò che finora, purtroppo, è spesso
mancato.
Dal momento che siamo nell'imminenza del Natale,
terminiamo con un pensiero su questa festa.
Nella
notte di Natale ascolteremo le parole dell'inno angelico:
«Pace in terra agli uomini amati dal Signore», il
cui senso non è: Sia pace, ma è pace; non un
augurio,
ma una notizia. «Il Natale del Signore - diceva san
Leone Magno - è il natale della pace».
Come ricambiare il dono infinito che il Padre fa al
mondo, dando per esso il suo Figlio Unigenito?
Se c'è
una gaffe da non fare a Natale è quella di riciclare un
regalo offrendolo, per errore, alla persona stessa da
cui si è ricevuto.
Ebbene, con Dio non possiamo che
fare tutto il tempo questa gaffe!
L'unico ringraziamento
possibile è offrirgli Gesù che è suo Figlio, ma
anche nostro fratello.
L'unico dono degno di Dio è
l'Eucaristia.
E a Gesù che dono faremo?
Un testo della liturgia
orientale di Natale dice: «Cosa possiamo offrirti, o
Cristo, per esserti fatto uomo sulla terra? Ogni creatura
ti reca il segno della sua riconoscenza: gli angeli i loro canti, i cieli la
loro stella, la terra una grotta, il
deserto un presepio. Ma noi ti offriamo una Madre
vergine!».
PER UN ESAME DI COSCIENZA BASATO SULLE BEATITUDINI
«Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di
Dio».
Io sono un operatore di pace?
Metto
pace tra le parti?
Come mi comporto nei conflitti di
opinioni, di interessi?
Mi
sforzo di riferire sempre e solo il bene, le parole positive lasciando cadere
nel vuoto il male, il pettegolezzo, quello
che può seminare
discordia?
C'è la pace di Dio nel mio cuore, e se no
perché?
|
Beati i pacifici