Meditazione n. 2
«BEATI VOI CHE ORA PIANGETE,
PERCHÉ RIDERETE!»
Le beatitudini non sono un codice morto che la
Chiesa deve ricevere e trasmettere il più fedelmente
possibile; sono una fonte di ispirazione perenne, perché
risorto e vivo è colui che le ha proclamate.
Ad esse
si applica quello che il poeta Charles Péguy dice di
tutte le parole di Cristo:
«Gesù non ci ha dato delle parole morte
che noi dobbiamo chiudere in piccole scatole
e che dobbiamo conservare in olio rancido...
Ci ha dato delle parole vive
da nutrire...
Le parole di vita
non si possono conservare che vive...
Siamo chiamati a nutrire la parola del Figlio di Dio.
È a noi che appartiene, è da noi che dipende
di farla intendere nei secoli dei secoli,
di farla risuonare...».
1. Un nuovo rapporto tra piacere e dolore
Riflettiamo sulla seconda beatitudine: «Beati gli afflitti perché
saranno consolati» (Mt 5,4).
In alcuni codici
e traduzioni moderne l'ordine tra la seconda e la terza beatitudine - quella
degli afflitti e quella dei miti - è invertito, ma questo non incide in nulla sul
significato di esse.
Nel vangelo di Luca, dove le beatitudini, in numero di quattro,
sono sotto forma di discorso diretto e sono
rafforzate da un «guai» contrario, la stessa beatitudine
suona così: «Beati voi che ora piangete, perché riderete...
Ma guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti
e piangerete» (Lc 6,21.25).
Notiamo
anzitutto che questa è l'unica beatitudine basata sull'idea di contrappasso.
Nelle
altre beatitudini il rapporto tra la
situazione attuale e quella futura è
basato sull'idea del compimento: i poveri sono beati
perché di essi è il regno dei cieli, i miti perché
possiederanno la terra.
Qui invece, tra la beatitudine e la sua
ricompensa, c'è un rovesciamento, un passaggio da
uno stato al suo opposto: dal pianto al riso, o, viceversa, dal
riso al pianto.
Il messaggio più formidabile è racchiuso proprio
nella struttura di questa beatitudine nella versione lucana.
Essa ci permette di cogliere la rivoluzione che il Vangelo
ha operato nei riguardi del problema di piacere e dolore.
Il punto di partenza - comune sia al pensiero
religioso che a quello profano - è la constatazione che,
in questa vita, piacere e dolore sono inseparabili; si
susseguono l'un l'altro con la stessa regolarità con cui
al sollevarsi di un'onda del
mare segue un avvallamento e un vuoto che risucchia indietro il nuotatore.
L'uomo cerca disperatamente di staccare questi due fratelli
siamesi, di isolare il piacere dal dolore.
Ma invano.
È lo stesso piacere disordinato che si ritorce
contro di lui e si trasforma in sofferenza. E questo, o
improvvisamente e tragicamente o un po' alla volta,
in quanto è per sua natura transitorio e genera presto stanchezza
e nausea.
È una lezione che ci viene dalla
cronaca
quotidiana e che l'uomo ha espresso in mille
modi nella sua arte e nella
sua letteratura.
«Un non so
che d'amaro - ha scritto il poeta pagano Lucrezio -
sorge dall'intimo stesso di ogni piacere e ci angoscia
già nel mezzo delle nostre
delizie».
Il piacere illecito è ingannevole, perché promette
quello che non può dare.
Prima di essere gustato,
sembra offrirti l'infinito e l'eternità; ma, una volta
consumato, ti ritrovi con niente in mano.
È il messaggio
tragico di tanta poesia moderna.
I «fiori del male»
non si è finito di coglierli, ci dice Charles Baudelaire,
che già appassiscono e mandano odore di putrefazione.
La
Bibbia dice di avere una risposta da dare a questo
dramma dell'esistenza umana.
La spiegazione è
questa.
C'è
stata, fin dall'inizio, una scelta dell'uomo,
resa possibile dalla sua libertà e dalla sua
stessa natura fatta di spirito e materia, che lo ha portato a orientare
esclusivamente verso le cose visibili l'insopprimibile
desiderio di gioia, di cui era stato dotato perché
aspirasse a godere del Bene infinito che è Dio.
Al
piacere, scelto contro la legge di Dio e simboleggiato
da Adamo ed Eva che gustano del frutto proibito, Dio ha permesso che seguissero il dolore e la
morte, più come rimedio che come punizione;
perché non avvenisse, cioè, che,
seguendo a briglie sciolte il suo
egoismo e il suo istinto, l'uomo distruggesse se stesso e il suo
prossimo.
Così al
piacere vediamo ormai
aderire, come la sua ombra, la sofferenza.
Cristo ha finalmente spezzato questa catena.
Egli,
«in cambio della gioia che aveva a portata di mano, si
sottopose alla croce» (cfr. Eb 12,2).
Fece, insomma, il
contrario di ciò che fece Adamo e che fa ogni uomo.
Scrive san Massimo il Confessore:
«La morte del Signore, a differenza di quella degli altri uomini,
non era un debito pagato per il piacere, ma
piuttosto qualcosa che era gettato contro il piacere stesso.
E così, attraverso questa morte, cambiò il destino
meritato dall'uomo».
Risorgendo da morte, egli ha inaugurato un nuovo
genere
di piacere: quello che non precede il dolore, come sua causa, ma lo
segue come suo frutto.
E non
solo il piacere puramente spirituale, ma
ogni piacere onesto, anche quello che
l'uomo e la donna sperimentano nel dono reciproco, nel generare la vita e nel vedere
crescere i propri figli o i propri nipoti, il piacere
dell'arte e della creatività, della bellezza,
dell'amicizia, del lavoro felicemente portato a termine.
Ogni
gioia che procede dal dovere compiuto.
Tutto questo è meravigliosamente proclamato dalla
nostra beatitudine che, alla sequenza riso - pianto, oppone
la sequenza pianto - riso.
Non si
tratta di una semplice
inversione dei tempi.
La differenza, infinita, sta nel fatto che nell'ordine proposto
da Gesù è il piacere,
non la sofferenza, ad avere l'ultima parola e, quel
che più conta, un'ultima parola che dura in eterno.
Il giudizio di Cristo sul riso e il pianto non ha senso,
tuttavia, soltanto nella prospettiva della vita eterna, ma illumina, almeno in parte, anche la vita presente.
Si tratta di sapere cosa significa la parola iniziale «beati», di
quale beatitudine o felicità si sta parlando.
Non si tratta di una felicità soltanto dei sensi, di semplice
euforia e spensieratezza, ma di un "benessere"
integrale e duraturo di tutta
la persona.
Il pianto e l'afflizione
sono proclamati beati anche perché rendono
più maturi, più profondi, più veri, più comprensivi
della sofferenza altrui.
In una parola, più umani.
Il Vangelo non condanna assolutamente l'allegria e
la gioia; le parole gioia, festa vi ricorrono, si può dire,
in ogni pagina.
Il riso e la festa diventano segno di
egoismo
quando, anziché segnare momenti di relax e di interruzione della fatica,
diventano un idolo, qualcosa che si pretende
per se stessi come diritto e come
condizione stabile di vita, anche a spese di sofferenza
altrui.
Diverso è il caso del riso e dell'allegria dei comici e dei
clown. Il loro scopo infatti è di far ridere, divertire e istruire gli altri, di
dare un momento di gioia a tutti.
Esso è un dono per tutti, almeno finché si mantiene
sul piano dell'arte e non scende alla volgarità e alla
satira astiosa. Quando fa ridere senza ridicolizzare.
Il film di Roberto Benigni La vita è bella, per esempio,
è piaciuto tanto perché lì la comicità è messa a
servizio dell'amore. In questo caso, l'amore di un padre che,
mediante il gioco e il riso, vuole risparmiare
al proprio bambino gli orrori della deportazione e del
campo di concentramento. Il protagonista è
un afflitto che si sforza di dare gioia, e questo, a modo suo, lo abbia
o no inteso il regista, rientra nel quadro della beatitudine
evangelica.
La beatitudine di Cristo non va intesa
solo al futuro: «Beati quelli che ora sono afflitti,
perché un giorno saranno consolati», ma anche al presente: «Beati
quelli che accettano di essere afflitti, perché
altri intorno a loro possano essere consolati».
2.
«Dov'è il tuo Dio?»
Ma adesso cerchiamo di capire chi sono esattamente
gli afflitti e i piangenti proclamati beati da Cristo.
Gli
esegeti escludono oggi, quasi unanimemente, che si tratti di afflitti solo in
senso oggettivo o sociologico, gente che Gesù
proclamerebbe beata per il solo fatto di soffrire e di piangere.
L'elemento soggettivo,
cioè il motivo del pianto, è determinante.
E qual è questo motivo?
I padri e gli autori spirituali antichi insistevano sul
motivo penitenziale, le lacrime
di pentimento per i peccati.
Gli autori moderni
propongono piuttosto un motivo esistenziale:
il pianto
di coloro che si sentono stranieri sulla terra, lontani
dalla patria, di coloro che si affliggono per la sofferenza immane che c'è nel mondo. Un pianto, per cosi
dire, cosmico, nella linea del paolino gemere
del creato e degli uomini nell'attesa
della piena redenzione (cfr. Rm
8,19-23), o del virgiliano:
c'è un pianto delle cose.
Io credo che non dobbiamo restringere il campo a
questi due soli motivi.
La via più sicura per scoprire
quale pianto e quale afflizione sono proclamati beati
da Cristo è di vedere perché si piange nella Bibbia e
perché egli stesso piange nel Vangelo.
Scopriamo così
che c'è un pianto di pentimento come quello di Pietro
dopo il tradimento, un «piangere con chi piange» (Rm
12,15) cioè di compassione per il dolore altrui, come pianse Gesù
con la vedova di Nain e con le sorelle di
Lazzaro; il pianto di esiliati che anelano alla patria,
come quello degli ebrei sui fiumi di Babilonia... E
tanti altri.
Io vorrei mettere in luce due dei motivi per cui si
piange nella Bibbia e per cui ha pianto Gesù che mi
sembrano particolarmente da meditare nel momento
storico che stiamo vivendo.
Nel Salmo 41 leggiamo:
«Le lacrime sono mio pane giorno e notte,
mentre mi dicono sempre: "Dov'è il tuo Dio?"...
Per l'insulto dei miei avversari
sono infrante le mie ossa;
essi dicono a me tutto il giorno: "Dov'è il tuo Dio?"».
Mai
questa tristezza del credente per il rifiuto spavaldo di Dio intorno a lui ha
avuto tanta ragion d'essere
come oggi.
Dopo il periodo di relativo silenzio
seguito alla fine dell'ateismo marxista, stiamo assistendo
a un ritorno di fiamma di un ateismo militante
e aggressivo, di marca in genere scientifica
o scientistica.
I titoli di alcuni libri recenti sono eloquenti:
Trattato di ateologia, L'illusione di Dio, La fine della
fede, Creazione senza Dio, Un'etica senza Dio, Dio
non è grande. La religione avvelena ogni cosa...
In uno di questi trattati si legge la seguente dichiarazione:
«Le società umane hanno elaborato vari mezzi
ordinari di conoscenza, generalmente condivisi, attraverso
cui si può accertare qualcosa. Chi afferma l'esistenza di un essere non
conoscibile con quegli
strumenti, deve accollarsi l'onere della prova. Per
questo mi pare legittimo sostenere che, fino a prova
contraria, Dio non c'è».
Con gli stessi argomenti si potrebbe dimostrare che
neppure l'amore esiste, dal momento che non è accertabile
con gli strumenti della scienza.
Il fatto è che la
prova dell'esistenza di Dio non si trova nei libri e nei
laboratori di biologia, ma nella vita; nella vita di Cristo prima di tutto, poi
dei santi, e degli innumerevoli
testimoni della fede.
Si trova anche nella tanto disprezzata
prova dei segni e dei miracoli che Gesù
stesso dava a conferma della sua verità.
È vero, come
osserva
il Lessing, che i miracoli servono a chi ne è
testimone, non a chi li sente raccontare, ma
i miracoli avvengono anche oggi,
sotto i nostri occhi. Si tratta di non
rigettarne a priori la possibilità, senza neppure
darsi pena di esaminarne le prove, e di non
rifiutarli in blocco solo perché si può dimostrare che alcuni di essi
erano falsi.
Motivo
di tristezza del credente, come per il salmista, è l'impotenza che sperimenta di
fronte alla sfida: «Dov'è il tuo Dio?».
Con il suo misterioso tacere Dio
chiama il credente a condividere la sua debolezza e
sconfitta, promettendo solo a queste condizioni la vittoria.
«La debolezza di Dio è più forte degli uomini»
(lCor1,25).
Per essere sincere e feconde, queste lacrime del credente
devono essere versate non solo a causa degli increduli,
ma per gli increduli, per genuina compassione,
non importa se da essi rifiutata o messa in ridicolo.
Scrive il filosofo Kierkegaard:
«Si parla tanto di pene e di miserie umane. Io cerco di
comprenderle, ne ho conosciuti anche diversi casi da vicino; si parla tanto di
vite sprecate. Ma sprecata è soltanto
la vita di quell'uomo che la lasciava passare, ingannato
dalle gioie della vita e dalle sue preoccupazioni, in modo che non diventò mai,
con una decisione eterna, consapevole di se
stesso come spirito, come "io"; oppure
- ciò che è lo stesso - perché mai si rese conto, perché
non ebbe mai l'impressione che esiste un Dio e che
egli, proprio egli, il suo "io", sta davanti
a questo Dio... Mi sembra di poter piangere per un'eternità, al pensiero
che esiste questa miseria!».
Madre Teresa di Calcutta, che di povertà e di miserie ne aveva
conosciute tante, non faceva che ripetere che la povertà più brutta è quella di
chi pensa di poter
fare a meno di Dio.
3. «Piangano i sacerdoti, ministri del Signore»
C'è anche un altro pianto nella Bibbia sul quale
dobbiamo riflettere, che non è un piangere sugli altri,
ma su noi stessi.
Ce ne
parlano i profeti.
Ezechiele
riferisce la
visione che ebbe un giorno.
La voce potente
di Dio grida a un misterioso personaggio «vestito
di lino e con una borsa da scriba in mano»:
«Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme
e segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano
e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono» (Ez 9,4).
La Chiesa ha "pianto e sospirato" in tempi recenti
per gli
abomini commessi nel suo seno da alcuni dei
suoi stessi ministri e
pastori.
Ha pagato un prezzo altissimo
per i casi di pedofilia del clero.
È corsa ai ripari,
si è data regole ferree per impedire che gli abusi si ripetano.
È venuto
il momento di fare anche qualcosa d'altro:
piangere davanti a Dio, affliggersi come
si affligge Dio per l'offesa fatta al corpo di Cristo e lo
scandalo recato «ai più
piccoli dei suoi fratelli».
È la
condizione perché da tutto questo male possa davvero venire del
bene e si operi una riconciliazione del popolo con Dio e con i propri sacerdoti.
«Suonate la tromba in Sion,
proclamate un digiuno,
convocate un'adunanza solenne...
Tra il
vestibolo e l'altare piangano
i sacerdoti, ministri dei Signore, e dicano:
Perdona, Signore, al tuo popolo
e non esporre la tua eredità al vituperio
e alla derisione delle genti.
Perché si dovrebbe dire fra i popoli:
Dov'è il loro Dio?» (Gl 2,15-17).
Queste parole del profeta Gioele contengono un appello
per noi.
Non si potrebbe fare lo stesso anche oggi:
indire un giorno di digiuno e di penitenza, almeno
a livello locale e nazionale, dove il problema
è stato più forte, per esprimere pubblicamente pentimento
davanti a Dio e solidarietà
con le vittime?
Mi danno il coraggio di dire questo le parole pronunciate
dal papa Benedetto XVI all'episcopato di
una nazione cattolica in una recente visita
ad limina:
«Le
ferite causate da simili atti sono profonde, ed è
urgente il compito di ristabilire la
confidenza e la fiducia quando queste sono state lese... In tal modo la
Chiesa si rafforzerà e sarà sempre più
capace di dare testimonianza della forza redentrice della Croce di
Cristo»
(Benedetto
XVI, Discorso ai vescovi della conferenza episcopale di Irlanda,
sabato 28 ottobre 2006).
Ma non dobbiamo lasciare senza una parola di speranza
anche gli sventurati fratelli che sono stati la
causa del male.
Sul caso di incesto avvenuto nella comunità
di Corinto, l'Apostolo sentenziò: «Questo individuo
sia dato in balìa di satana per la rovina della
sua carne, affinché il suo spirito possa
ottenere la salvezza
nel giorno del Signore» (1Cor 5,5).
La salvezza
del peccatore, più che il suo castigo, stava a cuore
all'Apostolo.
Questi nostri fratelli sono stati spogliati di tutto: ministero,
onore, libertà, e nessuno sa con quanta effettiva
responsabilità morale, nei singoli casi; sono diventati
gli ultimi, i reietti.
Se in questa situazione, toccati dalla grazia, si affliggono per
il male causato, uniscono
il loro pianto a quello della Chiesa, la beatitudine
degli afflitti e di coloro che piangono diventa di colpo
la loro beatitudine.
Potrebbero essere vicini a Cristo,
che è l'amico degli ultimi, più di tanti altri, me compreso,
ricchi della propria rispettabilità e forse portati,
come i farisei, a giudicare chi sbaglia.
Ciò non toglie, naturalmente, che si faccia il possibile e si
collabori a
tutti i livelli con la giustizia umana, perché questi
scandali non si ripetano e che si cerchi di aiutare anche spiritualmente le
vittime degli abusi.
4. Le
lacrime più belle
Abbiamo
evocato fin qui alcuni motivi di afflizione e di pianto dei cristiani di oggi,
ma non posso terminare senza accennare che esiste un altro tipo di lacrime.
Si può
piangere di dolore, ma anche di commozione
e di gioia.
Le lacrime più belle sono quelle che
ci riempiono gli occhi quando, illuminati dallo Spirito Santo,
«gustiamo e vediamo quanto è buono il Signore»
(Sal 34,9).
Quando
si è in questo stato di grazia, ci si stupisce
che il mondo e noi stessi non cadiamo in
ginocchio e non piangiamo di stupore e di commozione.
Lacrime
di questo tipo dovevano scendere dagli occhi di Agostino
quando scriveva nelle Confessioni:
«Quanto ci
hai
amato, o Padre buono, che non hai risparmiato il
tuo unico Figlio, ma lo hai dato per tutti
noi. Quanto ci
hai amato!».
Lacrime come queste vennero versate
da Pascal durante la notte in cui ebbe la rivelazione
del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe che si rivela
per le vie del vangelo; e, su un foglietto di carta
(trovato cucito all'interno della giacca dopo
la sua morte), egli scrisse: «Gioia, gioia, lacrime di gioia!».
Io penso che anche le lacrime con cui la peccatrice
bagnò i piedi di Gesù non erano lacrime solo di pentimento,
ma anche di gratitudine e di gioia.
Se in cielo si può piangere, è di questo pianto che è
pieno il paradiso.
A Istanbul, l'antica Costantinopoli,
visse intorno all'anno mille san Simeone il Nuovo
Teologo, il santo delle lacrime. Egli è l'esempio più
fulgido, nella storia della spiritualità cristiana, delle
lacrime di pentimento che si trasformano in lacrime di
stupore e di silenzio.
«Piangevo - racconta in una sua opera - ed ero in una gioia
inesprimibile».
Parafrasando la beatitudine degli afflitti, egli dice: «Beati coloro
che sempre piangono amaramente i loro peccati,
perché li afferrerà la luce e trasformerà le lacrime
amare in dolci».
Un giorno, in mezzo alle sue lacrime, san Simeone
sperimentò una gioia così forte che esclamò: «Cosa
ci può essere di più grande e più brillante di questo? A
me basta di essere così anche dopo la morte!».
La voce
di Cristo gli rispose: "Sei veramente meschino se ti
accontenti di questo. La tua gioia presente, rispetto a
quella futura, è come un cielo disegnato sulla carta, rispetto
al cielo vero"».
PER UN ESAME DI COSCIENZA BASATO SULLE BEATITUDINI
«Beati gli afflitti, perché saranno consolati».
Io
considero l'afflizione una disgrazia e un castigo, come
fa la gente del mondo, o una opportunità di rassomigliare
a Cristo?
Quali
sono i motivi delle mie tristezze: gli stessi di Dio o quelli del mondo?
Cerco di 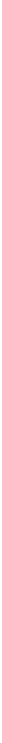 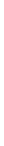 consolare
gli altri, o solo di essere consolato io? consolare
gli altri, o solo di essere consolato io?
So
custodire come un
segreto tra me e Dio qualche contrarietà, senza parlarne a destra e a sinistra?
|
Beati voi che piangete